Brevi cenni
storici-artistici sulla Badia Fiorentina
Le notizie qui
riportate sono state
liberamente riprese da “La Badia Fiorentina”di
Alessandro Guidotti, ed. Becocci, Firenze 1982.
|
L’attuale presenza dei monaci di Gerusalemme in questa
antichissima Badia sembra rispettare ancora dopo mille
anni la volontà della fondatrice, la marchesa Willa
di Toscana, che nel 978 ne promosse
l’edificazione e dette vita al nuovo centro ecclesiale
con generose e laute donazioni di beni terrieri,
donazioni e privilegi.
Poco
più tardi (996-997), il figlio Ugo, il
generosissimo “gran barone” (Dante, Paradiso, XVI, 28)
confermò ed aumentò le donazioni materne con tale
munificenza da oscurarne la memoria e rimanere, nel
ricordo dei Fiorentini, il fondatore della chiesa, del
cenobio e delle opere annesse. La sua memoria, celebrata
fin dall’antico con continuità, si protrae fino ad oggi
con la liturgia della Santa Messa ogni 21 dicembre. Di
questo illustre personaggio rimangono a memoria nella
chiesa la bella sepoltura di Mino da Fiesole e gli
stemmi della Marca di Toscana (a bande verticali bianco e rosso)
sopra l’arco dell’altar maggiore, in facciata su via
Ghibellina e su alcuni arredi lignei.
In
quei tempi antichi fece molta impressione la presenza in
città di monaci benedettini, solitamente lontani dai
centri urbani, ma allora, come oggi, quella inedita
situazione ben s’inseriva e corrispondeva alla vocazione
spirituale e al tempo stesso terrenamente concreta
dell’anima fiorentina. Sappiamo infatti dalla conoscenza
della storia religiosa ed artistica quanto quella
presenza monastica sia stata feconda!!! Quei
monaci, animati dal motto “ora et labora”, hanno
svolto infatti in Firenze e per Firenze nei secoli
un’opera molteplice e profonda, educando moralmente,
promuovendo socialmente, stimolando sul piano della
ricerca culturale.
Nello
stesso tempo elevarono anche un monumento d’arte!!! |
xx |

campanile
e facciata della Badia Fiorentina vista dalla via
Ghibellina |
Adesso questo
complesso architettonico è abitato dalle Fraternità Monastiche di
Gerusalemme, monaci in città, monaci che pur contemplativi, si
rendono testimoni del Vangelo lavorando nella città. Lo Spirito
Santo ha rinnovato l’antico “ora et labora” in questa
comunità contemplativa e concreta che incide moralmente sulla città
in modo assolutamente inedito, corrispondente ai nostri giorni.
Un’altra comunità è presente nella bella
chiesa di questo antico convento, la comunità dell’Opera di San
Procolo, con la celebrazione della Santa Messa ogni domenica, alle
ore 9, la “messa dei poveri” che il Professor Giorgio La Pira,
sindaco di Firenze negli anni 1951-58 e successivamente 1961-65,
volle fin dal dopoguerra, come momento di comunione spirituale
profonda con gli “ultimi”
|

Stemma della
Marca di Toscana all'interno della Badia |
xx |
NOTIZIE SULLA PRIMA CHIESA : 978-1284
L’area, nella quale furono eretti la chiesa ed il
convento voluti dalla marchesa Willa, era compresa tra
le mura del primo cerchio della città ed una più antica
chiesetta posta a nord, intitolata a Santo Stefano.
Quest’area, adesso difficilmente individuabile, era
posta tra via del Proconsolo, piazza San Firenze, via
della Condotta, via dei Magazzini e via Dante Alighieri.
Il convento fu dedicato alla Vergine Maria e, per volere
della fondatrice, doveva essere abitato da monaci
benedettini.
La
forma della prima chiesa era quadrangolare con tre
absidi semicircolari e orientamento tradizionale, ad
est, e facciata ad ovest.
|
|
Della
chiesetta primitiva rimangono pochissime tracce:
- la
base cilindrica del campanile del X secolo, ancora a
fondamento dell’attuale campanile gotico;
- un
avanzo di lastra marmorea, decorato in stucco del sec.X-XI;
- frammento
di mensa in marmo intarsiato, attualmente nell’altare nella
cappella Pandolfini sec.XII-XIII;
- una coppia
di bifore in marmo bianco e verde, provenienti probabilmente
dall’antica facciata, attualmente posta nel loggiato superiore
del chiostro degli Aranci, sec.X
|
xxxxx |

coppia
di bifore, sec. X (chiostro superiore) |
|
LA RISTRUTTURAZIONE DELLA
CHIESA : 1284-1307
|
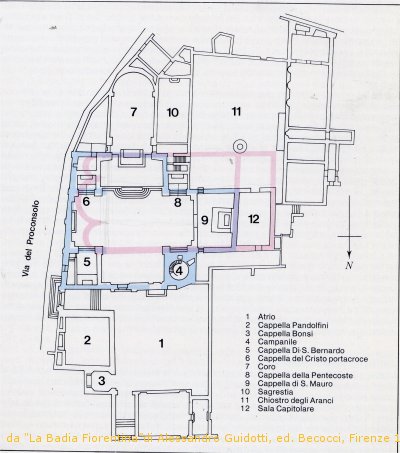
|
xxx |
La critica
attribuisce ad Arnolfo di Cambio, il celeberrimo
architetto di Palazzo Vecchio, di Santa Maria del Fiore e di Santa
Croce, nonché valente scultore, la ristrutturazione della chiesa a
partire dal 1284. I lavori si protrassero fino al primo decennio del
Trecento.
Le tre absidi
primitive furono allineate su via del Proconsolo, correggendo la
curvatura delle antiche mura che nel frattempo erano state demolite;
la grande parete sulla strada fu divisa da cinque lesene che
separano quattro alti e stretti finestroni archiacuti. Probabilmente
fu mantenuta l’antica dimensione della larghezza della chiesa, fu
realizzato un nuovo presbiterio rialzato di
vari gradini e
questo fu diviso in tre cappelle con crociere archiacute ed archi
ogivali all’ingresso. Le cappelle del presbiterio avevano affreschi
con storie di Cristo (a sinistra), storie della Vergine (al centro),
storie di Santi Martiri (a destra)
con vari gradini e questo fu diviso in tre
cappelle con crociere archiacute ed archi
ogivali all’ingresso. Le cappelle del
presbiterio avevano affreschi con storie di
Cristo (a sinistra), storie della Vergine (al
centro), storie di Santi Martiri (a destra) con
dedicazione a San Giovanni evangelista. I resti
di questi affreschi trecenteschi, (quelli
dell’abside centrale eseguiti da Giotto!!), sono
nei depositi degli Uffizi, ad eccezione di
alcuni con le scene della Vita di Cristo,
attualmente visibili nella cappella di San
Bernardo.
pianta del complesso di Badia,
secondo la ricostruzione di W.Paatz. in
nero l'attuale impianto, in rosso la
chiesa alto-medievale, in blu la chiesa
gotica (da
“La Badia Fiorentina”
cit., Firenze 1982.)
|
|
|

parete esterna dell'abside, sec. XIV (su via del
Proconsolo) |
x |
ll corpo centrale
della chiesa fu diviso in tre navate corrispondenti alle cappelle
del presbiterio; sappiamo che questa chiesa aveva la copertura a
capriate dipinte, il coro era transennato ed aveva un ingresso
secondario sul fianco settentrionale. Questo ingresso, accecato, è
ancora visibile dall’esterno del chiostro di accesso. Sull’altar
maggiore era stato collocato il magnifico polittico di Giotto,
attualmente esposto alla Galleria degli Uffizi. All’interno della
chiesa, sulla parete nord, sono ancora visibili resti degli antichi
affreschi del Trecento con motivi di finti paramenti murari e
piccole scene con storie di santo.
Entro il 1307 fu
completato il magnifico campanile, opera progettata da
Arnolfo di Cambio.
La facciata
gotica, con timpano e rosone, è ancora visibile nella parte
superiore (nella parte inferiore sono addossate costruzioni di
epoche successive) dal cortile interno ora della Pretura (accesso da
piazza San Martino, 2) o da un punto di vista sopraelevato.
|
x |

Il
Campanile visto dal Chiostro degli Aranci |
|
NOTIZIE SUGLI
INTERVENTI PRINCIPALI DELL’EDIFICIO CONVENTUALE
NEL QUATTROCENTO E
NEL CINQUECENTO
Durante la guida
dell’abate Gomezio Ferreira de Silva (1419-1439) l’area del
monastero si allargò considerevolmente fino alle attuali via dei
Gondi, dei Calzaiuoli, del Corso e del Proconsolo; in questo periodo
fu realizzato il “chiostro degli Aranci” (Bernardo Rossellino), si
incrementò la Biblioteca con rari e numerosissimi documenti antichi, libri preziosi manoscritti
e miniati, si acquisirono ricchissimi paramenti liturgici e si
costituì un patrimonio inestimabile di manufatti artistici.
Alla fine del
Quattrocento (1494 circa) Giovan Battista di Pandolfo Pandolfini
affidò a Bernardo da Rovezzano una serie di imponenti strutture: il
portale di accesso su via del Proconsolo con scalinata (distrutta
nel 1720), un elegante atrio a cinque campate con colonne a
capitelli corinzi (terminato entro il 1511), di accesso alla chiesa
della Badia e alla nuova cappella di famiglia, eretta sul luogo
dell’antichissima chiesetta di Santo Stefano, dove sappiamo che
Boccaccio nell’ottobre 1373 lesse Dante. Il nuovo atrio di Benedetto
da Rovezzano si apriva su un cortile rettangolare di fronte ad un
altro porticato, con sei campate, volte a crociera e capitelli
compositi realizzato nello stesso periodo, ma opera di altro
architetto, forse Giuliano da Sangallo. Tra il 1513 e il 1566 venne
eretta la contigua cappella Bonsi, intitolata a San Benedetto e già
contenente una scomparsa sepoltura con iscrizione.
Anche nel corso
del Cinquecento (a partire dall’aprile del 1588) il monastero si
ampliò di nuovi locali ad uso di dormitorio, foresteria, granai,
celle, magazzini nella direzione ovest/nord-ovest.
Il
chiostro degli aranci, particolare del
pozzo |
X |
 |
|

l'altar maggiore |
xx |
LA TRASFORMAZIONE DELLA
CHIESA: 1628-1663 circa
Nei primi
decenni del Seicento, su iniziativa dell’abate Serafino Casolani, fu
decisa una radicale trasformazione della chiesa e se ne affidò il
progetto e la realizzazione all’architetto Matteo di Marco Segaloni:
i lavori iniziarono il 2 febbraio 1628 e si protrassero all’incirca
fino agli anni 1660/70.
Gli interventi
principali previdero:
- il cambiamento
di accesso della chiesa che divenne sul lato nord, a fianco di
quello secondario del Trecento: di conseguenza fu chiuso e
mimetizzato l’accesso ad ovest;
- la
trasformazione della pianta:da croce latina irregolare a croce greca
regolare e geometrica;
- la collocazione
dell’altar maggiore: da est a sud;
|
|
- la
realizzazione di un nuovo coro molto profondo;
- la
realizzazione di un nuovo soffitto ligneo (1631) che nascose le
antiche capriate dipinte, ancor oggi esistenti sotto il soffitto a
lacunari;
- la
realizzazione delle due grandi cantorie nei bracci est ed ovest ad
opera di Felice Gamberai tra il 1628 e il 1631;
- la
realizzazione di un nuovo pavimento nel 1663 (l’antico, risalente
alla fine del XIII secolo, era in tarsie di mattoni in maiolica
colorata a motivi geometrici; furono così rimosse tutte le
antiche sepolture, alcune delle quali collocate nel chiostro degli
Aranci). Anche la pavimentazione seicentesca però non ci è
pervenuta, perché sostituita e rifatta di nuovo tra il 1968 e il
1972, in occasione di un impegnativo intervento di restauro che
previde nuovamente la rimozione delle sepolture seicentesche ;
- la
realizzazione di una nuova sacrestia sul luogo dell’antica
Biblioteca;
|
xx |

coro (lato destro) |
|

Liturgia alla Badia Fiorentina
|
xx |
- la
realizzazione tra il 1660 e il 1664 della cappella dedicata a San
Mauro, il cui patronato era della Famiglia Covoni. Questa cappella,
costruita per custodire una preziosa reliquia del Santo, fu
addossata alla facciata originaria e si trova sul fondo del braccio
ovest della crociera.
In questo periodo
quindi, cioè intorno al 1670, la chiesa assunse l’aspetto che ancora
oggi vediamo, ad eccezione della pavimentazione, rifatta
recentemente, tra il 1968 e il 1972.
Il convento
soppresso tra il 1808 e il 1811, perse nei suoi ambienti le antiche
destinazioni, divenuti per la maggior parte ad uso di uffici della
Pretura, abitazioni di privati, magazzini e negozi.
La Chiesa invece
ha continuato sempre ad essere aperta dai pochi monaci benedettini
rimasti fino al 1925, anno in cui divenne parrocchia. Nel 1998,
soppressa la funzione parrocchiale, fu affidata alle cure delle
Fraternità Monastiche di Gerusalemme.
|
|
L’ACCESSO DA VIA
DEL PROCONSOLO
Di fronte a via
Ghibellina e all’entrata del Bargello, affiancato alla imponente
parete dell’abside trecentesca risalta il portale che
Benedetto da Rovezzano realizzò per volere di Giovan Battista di
Pandolfo Pandolfini, in un periodo tra il 1494 e i primi anni del
Cinquecento.
Il portale, in
pietra serena, è composto da due colonne scanalate, che sostengono
una doppia architrave sulla quale è posto un arco a tutto sesto, con
duplici modanature entro il quale è stata collocata alla fine
dell’Ottocento, una bella lunetta in maiolica invetriata, con
Madonna, Bambino e angeli, a mezzo busto, opera di Benedetto
Buglioni (1461-1521). Lo stemma dei Pandolfini, una serie di delfini
fluttuanti, ricorre sui capitelli, sull’architrave e sui lati
esterni dell’arco. Sopra il portale un grande stemma del monastero a
bande verticali, parallele; un altro simile, più piccolo è posto
vicino ad una lapide che riporta i versi nei quali Dante ricorda Ugo
di Toscana.
Il portale poggia
sugli scalini eseguiti nel 1870, in sostituzione di una doppia rampa
fatta nel 1730, che a sua volta aveva sostituito le ben più antiche
“scalee”.
|
 |
xx |
L’ATRIO
L’accesso alla
chiesa è possibile da via del Proconsolo e da via Dante Alighieri
tramite un elegante porticato, commissionato dalla famiglia
Pandolfini a Benedetto da Rovezzano che lo eseguì entro il 1511.
Questo porticato,
composto da cinque campate delimitate ad ovest da eleganti colonne
lisce in pietra serena con capitelli corinzi e ad est da una lunga
parete su cui si aprono le cappelle Bonsi e Pandolfini, si apre su
un piccolo cortile rettangolare. Il lato nord del cortile è composto
dal muro della chiesa dove è ancora visibile un’antica porta
trecentesca ed il campanile di Arnolfo; il lato est è costituito da
un altro porticato con sei campate, volte a crociera, colonne e
capitelli compositi, opera probabile di Giuliano da Sangallo
(1445ca-1516) il lato sud è il muro dell’antico edificio
conventuale, adesso sede di uffici della pretura.
Nel corridoio
dell’atrio che da via Dante Alighieri arriva all’attuale ingresso
della chiesa vi è l’accesso alla cappella Bonsi e alla cappella
Pandolfini.
l'atrio, con a destra gli accessi
alla Cappelle Pandolfini e
Bonsi - sulla sinistra il
chiostro (in restauro) |
 |
xx |
LA CAPPELLA
PANDOLFINI
Questa cappella,
che si apre sull’atrio descritto precedentemente, occupa il luogo
dell’antica chiesa di Santo Stefano (chiesa in cui Boccaccio lesse
Dante dall’agosto all’ottobre del 1373 !!!). Fu commissionata dalla
famiglia Pandolfini a Benedetto da Rovezzano e realizzata intorno al
1511. Si accede da un semplice portale rinascimentale, architravato
in pietra serena, che conserva ancora gli originali battenti lignei
scolpiti ed intagliati con i motivi dei delfini. La pianta
dell’interno è quadrata; lo sviluppo verticale delle pareti è
suddiviso da cornici marcapiano in pietra serena sull’esempio
brunelleschiano, ma con proporzioni diverse; una cupola semisferica
copre l’ambiente; sulla parete dell’altare, al centro, si apre un
profondo e grande prospetto in pietra serena composto da arco a
tutto sesto su pilastri scanalati con doppi elementi di capitelli.
Sopra l’altare, ornato da stemmi dei Pandolfini e da un frammento di
mensa romanica, è posto un dipinto raffigurante “La lapidazione di
Santo Stefano”, opera di Giovanni Bilivert (1576-1644). Sull’antico
pavimento vi sono numerose iscrizioni, di cui una ricorda che
Roberto, nipote di Giovan Battista Pandolfini, volle realizzare quel
pavimento nel 1592.
Ai lati
dell’altare due piccole porte in pietra serena di accesso a
piccolissimi spazi compresi tra il muro trecentesco sulla strada e
quello della cappella; sopra le porte due belle monofore
rinascimentali, con cornici in pietra serena.
ingresso della Cappella
Pandolfini, ora in restauro |
|
LA CAPPELLA BONSI
Si tratta di un
piccolo vano che si affaccia sull’atrio d’ingresso, accanto alla
cappella Pandolfini, cui si accede da un antico portale ligneo
intagliato e sormontato dallo stemma di famiglia. Adesso questa
antica cappella è occupata da “Monastica” un piccolo luogo di
accoglienza dove vengono venduti prodotti di molteplici monasteri,
nonché pubblicazioni relative ai Monaci di Gerusalemme. La
costruzione della cappella risale ad un periodo di tempo tra il 1513
e 1566, fu dedicata a San Benedetto, è a pianta quadrata ed è
caratterizzata da una semplice divisione architettonica
rinascimentale in pietra serena. Al centro, nel pavimento in
laterizio, una lastra tombale.
 a
sinistra: portale d'ingresso sul
cortile, sec. XIV a
sinistra: portale d'ingresso sul
cortile, sec. XIV
a destra: ingresso alla Cappella
Bonsi, ora sede di "Monastica"
|
xxx |
 |
 |
xxx |
IL CAMPANILE
L’attuale
campanile, uno dei più belli in Firenze, è stato costruito sulla
base cilindrica del più antico campanile risalente al X secolo, è
stato progettato da Arnolfo di Cambio ed eseguito nei primi anni del
Trecento.
E’ formato dalla sovrapposizione di quattro piani a pianta
esagonale in pietra a vista. Ogni lato del campanile si apre con
bifore più piccole e con archi a tutto sesto le più basse, più
slanciate e con archi a sesto acuto le più alte.
La struttura
termina in alto con una cuspide molto pronunciata esagonale, alla
cui base sei piccole cuspidi con finestre quadrilobe.
Il campanile,
che ha subito nel tempo numerosi incidenti e manomissioni, è stato
restaurato nel 1900 e, più recentemente negli ultimi dieci anni.
Il campanile, visto
da Piazza San Firenze |
|
BREVE VISITA ALLA
CHIESA
Entrando in
chiesa siamo colpiti dall’eleganza e dalla chiarezza architettonica
di questo ambiente con pianta a croce greca. Davanti all’ingresso,
sopra una breve scalinata l’altare, una semplice mensa in pietra
serena, sormontata da una moderna croce in legno dipinto, in stile
bizantino. Dietro un magnifico arco trionfale che introduce al coro.
Sulla parete a sinistra dell’entrata un bel dipinto di Filippino Lippi, raffigurante “La Madonna che appare a San Bernardo”,
proseguendo a sinistra si apre la cappella di San Bernardo dove si
trovano affreschi staccati del primo Trecento e dove si apre un
piccolo spazio dove i monaci fanno accoglienza spirituale; sulla
parete del braccio est monumento funebre a Ugo di Toscana di Mino da
Fiesole, sormontato da una grande cantoria nella quale è inserita
“L’Assunzione della Vergine “di Giorgio Vasari. Segue una cappella
con altare e struttura architettonica in pietra serena dove è
custodito il Santissimo Sacramento; poi troviamo l’altar maggiore e
sul braccio ovest un’altra cappella, simmetrica alla precedente.
Sulla parete ovest si apre la cappella dedicata a San Mauro, che è
anche di accesso al chiostro degli Aranci e quindi agli ambienti
monastici. In questa cappella c’è pure l’ingresso al campanile.
Sopra l’entrata della cappella di San Mauro un antico e pregiato
organo del 1558, con cantoria. Proseguendo un monumento funebre di
Mino da Fiesole dedicato a Bernardo Giugni, poi un dossale marmoreo
ancora di Mino da Fiesole con Madonna e Bambino e i Santi Lorenzo e
Leonardo; infine sulla parete della controfacciata arcosolio di
Bernardo Rossellino con monumento funebre a Giannozzo Pandolfini e
resti di affreschi trecenteschi. La chiesa ha un bellissimo soffitto
ligneo dei primi decenni del Seicento intagliato e riquadrato con
ricchi lacunari.
DESCRIZIONE DELLE
OPERE D’ARTE NELLA CHIESA
Citiamo le più
importanti emergenze artistiche in ordine cronologico,indicando la
loro collocazione attuale in chiesa: |
|
·
Quattro stralci di affreschi raffiguranti la ”Flagellazione di
Cristo”,”Pilato in carcere”,”Giuda impiccato”, la “Salita di Gesù al
Calvario”.
Sono affreschi staccati durante il restauro eseguito tra il 1958 e
1960, attualmente posti nella cappella di San Bernardo,
originariamente dipinti sui muri di una delle cappelle del
presbiterio, quella posta a sinistra dell’abside centrale, di
patronato Giochi Bastari. Sono opera di un valente pittore
fiorentino molto vicino a Giotto, da alcuni ritenuto Nardo di
Cione, che li eseguì verso il 1301 con uno stile di grande
qualità espressiva, chiarezza formale e realismo sintetico
·
Resti di affreschi del tardo Trecento con finti paramenti murari e piccole
storie di Santo nella parete della controfacciata. Questi affreschi
ci lasciano intuire l’aspetto della chiesa gotica, decorato
vivacemente
·
Tomba ad arcosolio di Giannozzo Pandolfini,
attribuita alla scuola di Bernardo Rossellino, realizzata appena
dopo il 1456, anno di morte di questo personaggio importante
nella vita politica e diplomatica di Firenze. La sepoltura, che si
trova nel settore ovest della controfacciata, è costituita da un
sarcofago, sopra un basamento ripartito da lesene, incassato entro
una lunetta incorniciata da festoni e sorretto da due delfini. Sulla
parte frontale l’epigrafe sorretta da una coppia di putti alati e
sul coperchio lo stemma dei Pandolfini entro una ghirlanda.
cappella di San Bernardo -
"Salita di Gesù al
Calvario", sec. XIV |
xx |
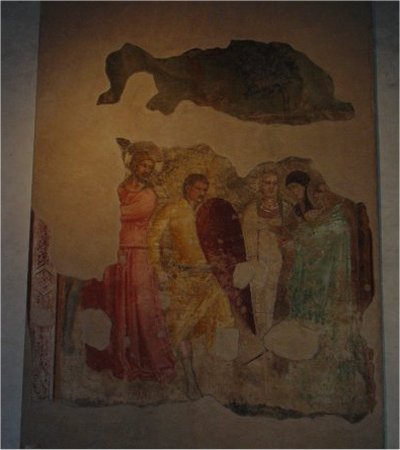 |
 |
a sinistra: tomba di
Giannozzo Pandolfini
sulla parete di fondo
a destra: resti di
affresco del Tardo
Trecento |
 |
|
·
Monumento funebre a Bernardo Giugni, opera di
Mino da Fiesole che la compì, tra il 1466 e il 1469,
attualmente posta nella parete destra del braccio a ovest della
crociera, in origine nella navata gotica meridionale. La struttura
della tomba, ripresa da Bernardo Rossellino, e molto simile a quella
che lo stesso artista fece ad Ugo di Toscana nella stessa chiesa,
poggia su un basso zoccolo: entro una grande struttura
rinascimentale è collocata la figura del defunto distesa su un
sarcofago con iscrizione e due angiolini alati. Al di sopra una
specchiatura tripartita in porfido rosso ed allegoria della
Giustizia al centro. Entro la grande lunetta che poggia su
un’architrave con ai lati due stemmi Giugni, una scultura con
ritratto di Bernardo, cancelliere della Repubblica fiorentina. Sulla
sommità, al di fuori dell’arco, una statuetta con cartiglio.
·
Dossale marmoreo con Madonna e Bambino
fiancheggiati dai Santi Lorenzo e Leonardo, eseguito da Mino da
Fiesole tra il 1464 e il 1470 per un’opera più complessa
commissionatagli da Dietisalvi Neroni per la sua cappella in San
Lorenzo. Quest’opera non fu completata come previsto, perché il
committente fu esiliato. Fu lasciata in deposito alla Badia: nel
1470 i monaci saldarono all’artista l’opera realizzata nella forma
in cui la vediamo e la collocarono in sacrestia.
|
xx |

dossale marmoreo di
Mino da Fiesole |
|

Monumento
Funebre a Ugo di
Toscana |
|
·
Monumento funebre ad Ugo di Toscana eseguito da Mino da Fiesole
tra il 1469 e il 1481, posto sulla parete che delimita il
braccio est della crociera, in corrispondenza dell’antico altar
maggiore, dove si trovava il celebre polittico di Giotto, ora agli
Uffizi. Il corpo del marchese era stato tumulato in Badia fin dal
1001, data della sua morte, in una cassa di ferro ed in un’urna di
porfido.
Mino da Fiesole, valente scultore fiorentino del Rinascimento,r ealizzò
questo monumento, commissionatogli fin dal
1469, in marmo
bianco di Carrara, con alcuni inserimenti in porfido rosso scuro.
Mino riprese lo schema usato da Bernardo Rossellino nel monumento a
Leonardo Bruni in Santa Croce: infatti ha organizzato la tomba
poggiandola su un basamento ornato da due angeli alati che reggono
l’iscrizione su cui è ricordato l’anno del compimento dell’opera,
1481. Sopra il basamento è realizzata una struttura architettonica
rinascimentale, delimitata alle estremità da due lesene con
capitelli classicheggianti su cui poggia un arco a tutto sesto.
Entro questa architettura, nella parte inferiore di forma
rettangolare è inserito il sarcofago con sopra il defunto disteso
sul letto funebre, sopra di lui, al centro, su un fondo diviso in
tre specchiature, un’allegoria della Carità. Sopra l’architrave che
delimita la sezione rettangolare dalla lunetta superiore, un tondo
con “Madonna e Bambino Gesù”. Ai lati del sarcofago, in basso, fuori
dal prospetto architettonico, due putti con lo stemma, a bande
verticali rosse e bianche, della Marca di Toscana. Quest’opera d’arte,
considerata il capolavoro di questo artista, è un bell’esempio
dell’arte fiorentina rinascimentale che dimostra di voler unificare
le “arti maggiori” (architettura, scultura, pittura) in una
rappresentazione di grande armonia compositiva, di realismo
idealizzato, di comprensione e rielaborazione dell’arte antica
romana, oltre che porsi come memoria delle virtù degli uomini
illustri per i contemporanei ed i posteri,virtù da imitare e
celebrare.
|
|
·
Dipinto raffigurante L’Apparizione della Madonna a San Bernardo, opera
di Filippino Lippi
che la eseguì probabilmente tra il 1482 e il 1486 per la
cappella di famiglia Del Pugliese nel monastero di Santa Maria delle
Campora di Marignolle, presso Firenze. Questo dipinto arrivò alla
Badia durante l’assedio del 1530, per motivi di sicurezza. Sappiamo
che il convento delle Campora dipendeva dai monaci della Badia
fiorentina. Il committente, Piero di Francesco Del Pugliese, è
raffigurato di profilo, a mani giunte, in basso a destra mentre
osserva la scena dell’Apparizione della Vergine a San Bernardo, in
estasi, sul fondo a destra in alto i monaci osservano, fuori del
convento, meravigliati la luce di cui non comprendono il
significato. Un particolare curioso è la raffigurazione di un
demonio coperto di pelliccia e con minacciose zanne nascosto nella
roccia sotto al santo. Il dipinto di Filippino colpisce per la
nitidezza del disegno, lo splendore dei colori, la delicatezza e la
dolcezza delle fisionomie molto espressive, e belle proporzioni e la
sapiente organizzazione della composizione e della profondità.
Tuttavia il disegno dell’artista, inquieto e sinuoso, conferisce
alla scena un dinamismo psicologico molto innovativo rispetto al
clima artistico fiorentino, che gravitava alla corte di Lorenzo il
Magnifico di cui Botticelli era senza dubbio il protagonista, dal
quale si era invece appena allontanato Leonardo in cerca di altro
tipo di committenze a Milano
Filippino Lippi:
"Apparizione della Madonna a San Bernardo" (particolare)
|
xx |
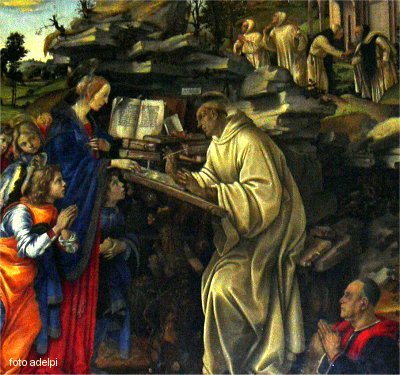 |
|
Il coro
ligneo
costituito
da trentadue
stalli in
noce
intagliato e
intarsiato,
eseguito tra
il 1501 e il
1502 dai
maestri
legnaioli
Francesco e
Marco Del
Tasso.
Questo coro
si trovava
nella chiesa
arnolfiana
nello spazio
al centro
della navata
centrale,
prima
dell’inizio
delle navate
laterali.
Nello
spostamento
della nuova
sistemazione
seicentesca
furono fatte
delle
modifiche
perché le
parti si
adattassero
alle nuove
esigenze,
come la
critica ha
rilevato in
occasione
dei restauri
eseguiti tra
il 1969 e il
1972. La
serie dei
sedili di
sinistra si
apre con il
bue (San
Luca) e si
chiude con
l’aquila
(San
Giovanni);
quelli di
destra si
inizia con
il leone
(San Marco)
e termina
con
l’angelo
(San
Matteo).
Bellissimi
sono i
braccioli
terminali,
molto
espressive
le sculture,
mirabili le
tarsie dei
pannelli
lignei. |
|

badalone del coro
sec XVI |
xxx |
Gli stessi legnaioli
eseguirono lo
stupendo badalone,
ancora in loco: su
una base massiccia a
sezione esagonale
poggia una colonna
rivestita di intagli
ed un elemento
piramidale a tre
piani inclinati sui
quali si appoggiano
i corali. Ad un
altro maestro della
stessa epoca,
anonimo, è invece
attribuito il bel
candelabro ligneo
per il cero
pasquale: sulla base
triangolare, su cui
è intagliato lo
stemma della Badia,
e sullo allungato
nodo sporgono
protromi umane a
tutto rilievo; il
corpo dell’oggetto,
un unico pezzo,
risulta dalla
sovrapposizione di
strutture variamente
sagomate che ora si
restringono, ora si
allargano in
armonioso rapporto
candelabro ligneo
sec. XVI |
xxx |
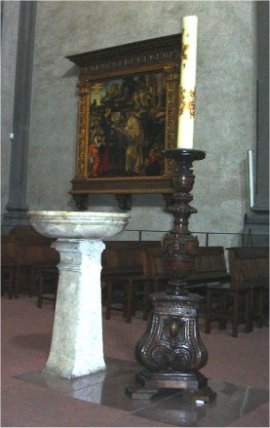 |
|
·
Organo : opera di Onofrio Zeffirini da Cortona
che lo terminò nel 1558
Si tratta dell’unico organo di questo celebre costruttore
di strumenti rimasto pressoché integro fino ad oggi: infatti gli
altri importanti organi da lui eseguiti (in Sant’Ambrogio, nella
chiesa di Ognissanti, in Santa Trinita, in Santa Croce, nel Duomo)
sono stati o smembrati o manomessi. A questo bellissimo organo
infatti mancano solo l’antica tastiera e una decina di canne piccole
su un complesso di 416! Le fonti antiche ricordano la grande fama
dello Zeffirini, quasi un mito durato fino al secolo scorso in
questa specialità artistica: il restauro, compiuto tra il 1978 e il
1979 recuperando interamente le particolari sonorità, anche
manieristiche, di questo strumento, ha confermato la fama del suo
costruttore. L’organo è inserito entro strutture lignee dorate,
dipinte ed intagliate da Felice Gamberai (attivo in Badia
negli anni 1628-1631) nelle quali sono inseriti dipinti
raffiguranti a sinistra, a figura intera un “San Michele”, e sopra,
entro un tondo, il volto di “Santa Cecilia” dipinti nel 1635 da
Francesco Furini; a destra dell’organo un “San Giovanni Battista“
con sopra, entro un tondo, il volto di “David” dipinti nello stesso
anno da Baccio del Bianco.
|
xx |
 |
 |
|
·
Dipinto raffigurante “Assunzione di Maria Vergine” con i Santi
Benedetto, Nicola di Bari e Santa Scolastica a sinistra e a destra i
Santi Lorenzo, Agostino e Giustina, opera di Giorgio Vasari
(1511-1574) che realizzò e sistemò sull’altare maggiore della chiesa
il 2 febbraio 1568, prendendo il posto dell’antico polittico di
Giotto, adesso esposto alla Galleria degli Uffizi. L’opera
del Vasari che comprendeva pure una predella, di cui restano due
parti a Palazzo Pitti, fu smembrata in occasione della
trasformazione seicentesca della chiesa ed inserita nella grande
cantoria posta nel braccio est della chiesa, realizzata da Felice
Gamberai intorno al 1628.
Cantoria di
Felice Gamberai,
con "Assunzione
di Maria Vergine"
di Giorgio
Vasari |
|

sopra:
Dipinto
raffigurante “Cristo porta la croce con la
Veronica” dipinto da Giovan Battista Naldini (1537ca.-
1591) verso il
1570, posto nell’altare della cappella a sini-
stra dell’altare
maggiore.
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a fianco:
Dipinto
raffigurante la
"Pentecoste"
dipinto da
Mirabello
Cavalori
(1510-20ca.-1572).
posto
sull'altare
della cappella a
destra
dell'altar
maggiore |
 |

sopra: Madonna
con Bambino (XIX
secolo)
a destra:
"Croce Gloriosa"
di Giovanna Faccincani
|
|
·
Soffitto ligneo intagliato a cassettoni ottagonali e rettangolari disposti entro una
cornice percorsa ininterrottamente da motivi decorativi fogliacei e
sostenuta da finte mensole di acanto eseguito tra il 1628 e il 1631
da Felice Gamberai, che realizzò qui il suo capolavoro tanto
da venir richiesto per altri lavori simili fuori Firenze.
·
All’esterno dell’arco del coro si possono osservare, a sinistra una
"Immacolata Concezione", a destra una “Annunciazione”,
opera di un pittore anonimo del primo Settecento e al centro
“Martirio di Santo Stefano” opera di Gian Domenico Ferretti.
Lo stesso pittore eseguì anche, all’interno del coro,
“l’Incoronazione
della Vergine” e “l’Assunzione della Vergine”, nel 1734 circa.
Le figure dei “Profeti” e le finte architetture sulle
pareti all’interno del coro furono eseguite da Pietro Anderlini nel
1734.
·
Cappella di San Mauro
(braccio ovest della crociera, addossata all’antica
facciata) progettata dall’architetto Giovan Battista Balatri tra il
1660 e il 1664 su commissione della famiglia Covoni che la volle per
custodire una preziosa reliquia di quel Santo. Sull’altare
un dipinto ”San Mauro che risana gli storpi“ di Onorio
Marinari (1627-1715), sul soffitto “San Mauro in gloria” di
Vincenzo Meucci (1699-1766), le finte architetture dipinte sulle
pareti sono di Pietro Anderlini. Un’epigrafe posta sotto e dietro la
mensa dell’altare ricorda che la decorazione pittorica fu eseguita
nel 1737.
·
Due piccole statue raffiguranti “Madonna con Bambino” e “San Francesco” poste la prima
appena fuori della cappella a destra dell’altar maggiore, l’altro
all’interno della cappella di San Bernardo, di un artista della
prima metà dell’Ottocento.
·
Croce Gloriosa un grande crocifisso sagomato dipinto su
tavola in stile bizantino posto sopra l’altar maggiore opera di
Giovanna Faccincani, del 2001

|
|
Due icone
in stile
bizantino,
raffiguranti
la
"Vergine con
Bambino"
e "San
Giovanni
Battista"
poste sui
pilastri
all'ingresso
del coro,
rispettivamente
a sinistra e
a destra,
opera di
Giovanna
Faccincani
(2008) |
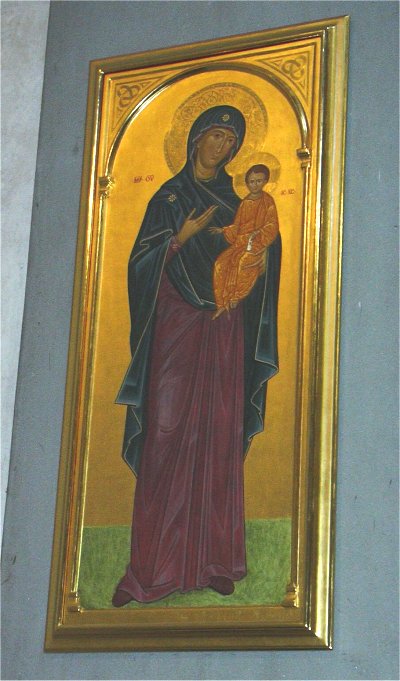 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a sinistra:
Vergine con
Bambino
a destra: San
Giovanni
Battista
di Giovanna
Faccincani |
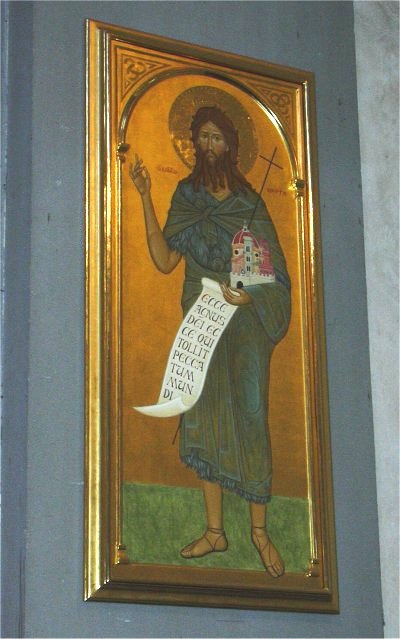 |
|
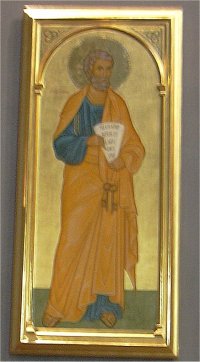 |
Sulle colonne
antistanti il
presbiterio
a sinistra:
San Pietro
Apostolo
a destra: San
Paolo Apostolo
Icone di Giovanna Faccincani
(maggio 2011) |
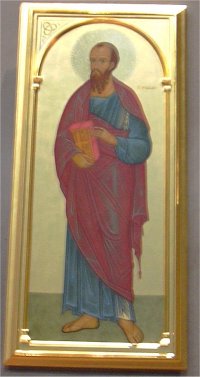 |
|
IL CHIOSTRO DEGLI
ARANCI
Si accede a
questo bel chiostro, posto all’interno del complesso monastico e
così denominato dagli aranci che vi furono piantati fin dall’antico,
dalla cappella di San Mauro e/o dalle scale della sacrestia. Fu
realizzato per volere di Filippo di ser Ugolino Pieruzzi, celebre
umanista fiorentino, tra il 1432 e il 1438 su progetto di Bernardo
Rossellino. E’ formato da due porticati sovrapposti ad archi
ribassati (tre sui lati brevi, cinque sugli altri) che poggiano su
colonne in pietra serena con capitelli ionici. I muri di separazione
tra i due piani sono interrotti da cornici marcapiano orizzontali e
lesene verticali che collegano le colonne dei due piani. Al centro
del chiostro un bel pozzo quattrocentesco. Sulle pareti del
piano inferiore si segnala, tra le numerose memorie di iscrizioni,
lapidi e frammenti architettonici, l’ingresso alla più antica sala
capitolare .
chiostro
degli aranci: il piano superiore |
xxxx |
 |
|
Al piano
superiore sulle lunette delle pareti dei lati settentrionale, occidentale
la prima campata del meridionale, sono ancora visibili
gli affreschi con storie della
Vita di
San
Benedetto,
che
alcuni
attribuiscono
a
Giovanni
di
Consalvo,
un
pittore
portoghese
compatriota
dell’allora
abate Gomezio che è documentato nei libri
dei creditori negli anni 1436-1439, altri ad un pittore fiorentino,
ancora anonimo, denominato “Maestro del chiostro degli Aranci”. Si
tratta di scene eseguite con vivo realismo e piacevole disegno
secondo l’esempio dei maggiori maestri fiorentini del tempo,in
particolare del Beato Angelico. |
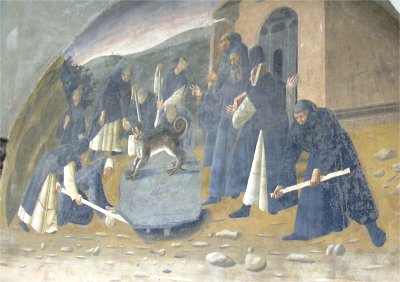
chiostro
superiore:
affreschi
sulla
vita
di
San
Benedetto |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
 |
 |
|
Partendo
dall’angolo nord occidentale vi sono raffigurati i seguenti episodi:
·
San
Benedetto giovane parte da Roma.
·
San
Benedetto, grazie alle preghiere, compie il miracolo di aggiustare
il vaglio della nutrice.
·
San
Benedetto viene vestito monaco da Romano; il monaco Romano assiste
Benedetto a Subiaco; un angelo appare ad un sacerdote mentre
consuma il pranzo pasquale rimproverandolo di non pensare alla fame
sofferta da Benedetto;
·
San
Benedetto si getta nudo in un cespuglio di rovi per vincere le
tentazioni e poi assorto in estasi (questa lunetta fu eseguita più
tardi dal pittore Agnolo Bronzino, nei primi decenni del
Cinquecento).
·
San
Benedetto, seduto su un cassone, spezza benedicendolo un bicchiere
colmo di vino offertogli da dei confratelli di una confraternita che
lo avevano voluto come capo. Tra i volti dei monaci, uno, calvo e
sorridente che ammicca verso l’osservatore e sopra il cui capo ci
sono le iniziali I.M. è stato indicato come possibile autoritratto
dell’autore del ciclo.
|
|
·
San
Benedetto libera un monaco da un diavolo battendolo sulle spalle con
un bastone.
·
San
Benedetto recupera miracolosamente un falcetto caduto in un lago da
un barbaro mentre ripuliva un terreno di proprietà del monastero.
·
Il
monaco Mauro è inviato da San Benedetto a salvare il collega Placido
caduto nel lago mentre attingeva l’acqua;
·
Prete Fiorenzo offre a San Benedetto del pane avvelenato; nel
refettorio interviene un corvo che lo prende prima che il Santo lo
consumi.
·
San
Benedetto allontana con la preghiera un diavolo che impediva a dei
monaci di sollevare un macigno: allusione ad un episodio della
costruzione del monastero di Montecassino;
·
San
Benedetto resuscita un giovane religioso rimasto sepolto sotto un
muro crollato durante i lavori a Montecassino;
·
San
Benedetto si accorge dell’imbroglio tesogli dal re Totila che aveva
mandato al suo posto uno scudiero volendosi accertare dei poteri del
Santo.
|
xx |
 |
 |
xxxx |
·
San
Benedetto predice a re Totila la prossima morte
Seguono sei lunette con le sinopie degli affreschi
ricordati; le altre sei sinopie si trovano nei Depositi delle
Gallerie.
|
|


